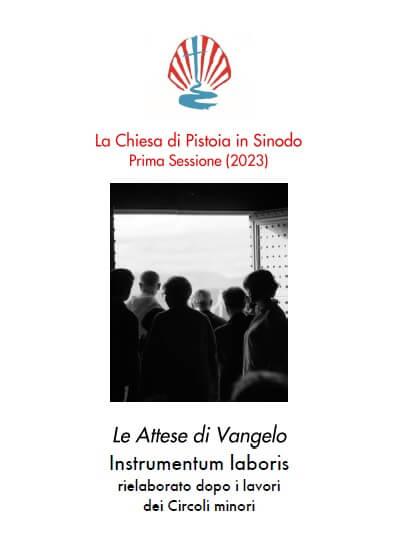Presentato il nuovo Instrumentum laboris modificato dopo i Circoli Minori. Tutte le novità del testo rivisto dai Sinodali
Venerdì 9 giugno, all’Assemblea plenaria del Sinodo Diocesano è stato presentato il testo dello Strumento di lavoro modificato dopo il lavoro dei Circoli Minori. Si tratta di un testo non definitivo, una bozza che in occasione della prossima assise, prevista per giovedì 15 giugno, sarà sottoposta a modifiche, tagli o integrazioni.
Don Cristiano D’Angelo, vicario generale della Diocesi, ha illustrato il nuovo testo di lavoro segnalandone le novità.
I principali cambiamenti sono i seguenti: in primo luogo lo spostamento dell’ultima proposizione, quella dedicata alla “memoria grata” che è stata estratta dalle proposizioni e posta come introduzione al testo. Posta all’inizio lascia emergere il tono positivo dell’approccio al lavoro. Un altro spostamento importante è quello legato alla prima proposizione, intitolata “Attesa di Vangelo” , prima quasi al termine, ora inserita come prima proposizione, così da fare dell’Attesa di Vangelo, il punto di vista principale dell’intero lavoro.
Nella prima proposizione inoltre, sono stati esplicitati in un nuovo paragrafo “i nuovi cammini educativi” che è chiamata a proporre la Chiesa. Altro importante cambiamento è l’introduzione di una proposizione dedicata alla famiglia e l’attenzione a un tono più positivo, che abbandona il ruolo e il peso della “coda pandemica”. Altri cambiamenti prevedono alcune aggiunte o ritocchi ai paragrafi.
L’ATTESA DI VANGELO
La prima proposizione vede semplificato il titolo e aggiunta una maggiore insistenza sull’esigenza di ridire la centralità del Vangelo e di proporlo come buona notizia per tutti, nella consapevolezza che il Vangelo rende “tutti” discepoli (preti, suore, religiosi, laici…). È stata poi aggiunto un riferimento alla bellezza dell’esperienza sinodale, con l’invito a una cura più stabile della vita spirituale.
Nuovi cammini educativi
Il secondo paragrafo, dedicato ai nuovi cammini educativi presenta un’aggiunta più ampia che propone di investire in questo ambito con un ampio coinvolgimento, evidenziando la novità di uno stile di accoglienza che permetta al messaggio evangelico di poter essere più facilmente riconoscibile. L’oggetto di questi nuovi cammini è il Vangelo nel suo stretto rapporto con la vita quotidiana. Il testo richiede poi, di avere dei contenuti educativi comuni, nell’iniziazione cristiana come in altri ambiti, pur lasciando spazio alla creatività. Allo stesso tempo è stato sottolineato il tema del linguaggio, oggetto di numerose segnalazioni che spingono all’uso di un linguaggio più comprensibile e inclusivo.
IL TEMPO CHE STIAMO VIVENDO
La nuova seconda proposizione, dedicata al “Tempo che stiamo vivendo” ha ridotto il riferimento alla pandemia; il paragrafo è stato asciutto e integrato con il tema della guerra e quello della crisi energetica, della conversione ecologica, della crisi ambientale. Gli aspetti negativi individuati nel testo sono stati ritenuti presenti nella società odierna indipendentemente dalla pandemia, che semmai li ha evidenziati.
L’ATTESA DI RELAZIONI UMANE SIGNIFICATIVE
Nella terza proposizione, dedicata ai legami fondamentali, è stato aggiunto il tema della iperconnessione e il senso di solitudine e di smarrimento che si vive nel nostro tempo. Si parla di solitudine subita e isolamento voluto, cercando di mettere in risalto non soltanto gli aspetti negativi ma anche quelli positivi, cioè l’impegno a farsi prossimi agli altri. Si parla poi del prendersi cura, inteso come una grande benedizione, per chi la offre e chi la riceve. Infine il testo presenta la bellezza e la consolazione che derivano dal riconoscersi l’uno nell’altro.
L’ATTESA DI COMUNITÀ FRATERNA E MISSIONARIA
La quarta proposizione, legata all’attesa di fraternità, vede una semplificazione, cercando di limitare le parole e fare più chiarezza. Si è cercato di mettere più in risalto la vita consacrata specificandone la ricchezza delle espressioni, con l’aggiunta del tema della testimonianza.
L’ATTESA DI FAMIGLIA
La quinta proposizione è completamente nuova, ed è dedicata alla famiglia. Si valorizza il ruolo fondamentale e insostituibile della famiglia, pur tenendo conto dei grandi cambiamenti del nostro tempo. Si sottolinea la fatica o l’assenza della trasmissione della fede nelle famiglie che contrasta con il fenomeno della richiesta di sacramenti che pure non sempre corrisponde ad una crescita della fede. Emerge una certa impreparazione ad affrontare i cambiamenti nelle famiglie. Si auspica un’attenzione alle famiglia, una creatività pastorale nei confronti delle famiglie, presentate in tutta la loro varietà e complessità (coppie dello stesso sesso, separate, conviventi..).
LA DONNA. DONO E CORRESPONSABILITÀ
La sesta proposizione, dedicata alla donna, è una delle più discusse ed è stata riscritta in maniera piuttosto importante. Il primo cambiamento riguarda il termine di corresponsabilità, a cui i sinodali hanno preferito il termine reciprocità o complementarietà. Nel testo è poi ribadito come soltanto a partire dalla radice l’uomo e la donna sono chiamati ad avere un ruolo e un servizio nella realtà ecclesiale. Sono stati poi criticati termini come “empatia”, “capacità di ascolto”, intesi come tipicamente femminili. Molti gruppi li ritenevano superati dalla mentalità di oggi. Infine si indica una novità, la necessità di una teologia della donna, con riferimento al ruolo della donna e al diaconato femminile. Sono emerse su questo punto molte divergenze: frutto delle posizioni del clero, poco avvezzo a conoscere le donne? Frutto di considerazioni ancora sessiste?
LE ATTESE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI: ASCOLTO, CURA E INTERGENERAZIONALITÀ
Nella settima proposizione si parla di giovani e anziani. Anche in questo caso sono piuttosto importanti le modifiche apportate. Si è ritenuto di dover attenuare le conseguenze della pandemia, evidenziando anche gli aspetti positivi del mondo giovanile, capace di risorse, di impegno, di creatività. È stata poi riconosciuta l’esigenza di nuovi spazi educativi e di proporre percorsi educativi per quei giovani che la società mette ai margini. In questa proposizione sono emerse due posizioni diverse tra i sinodali: quella di chi contesta e critica i social media e quella di chi ne sottolinea le possibilità. Dei giovani si evidenzia comunque il desiderio di Dio, di risposte di senso. Si ritiene che, pur all’interno di proposte dedicate, proprie di pastorale giovanile, la realtà giovanile debba essere oggetto dell’interesse di tutta la comunità. Allo stesso tempo i giovani sono stati considerati essi stessi protagonisti e non solo destinatari della proposta cristiana.
I giovani e il tempo libero
Nel paragrafo dedicato ai giovani e il tempo libero si è cercato di valorizzare il ruolo della scuola e l’esigenza di proporre percorsi abitabili da giovani e anziani.
Gli anziani, i giovani e l’intergenerazionalità
Degli anziani è stato ribadito il ruolo educativo, la ricchezza narrativa, l’importanza di creare occasioni di incontro e socialità tra generazioni diverse.
LE ATTESE DEI MIGRANTI
L’ottava proposizione, dedicata alle attese dei migranti, vede un cambiamento nel titolo dove si legge “Tutti siamo stranieri”. Nel testo si è poi passati dal fenomeno dei “migranti” al fenomeno “delle migrazioni”, per indicare un fatto epocale e non soltanto episodico o legato a certi individui. Il nuovo testo segnala alcune cause delle migrazioni per avere una lettura più completa del fenomeno, che i cristiani dovrebbero imparare a vedere in maniera diversa, impegnandosi a conoscere senza giudicare.
Altra novità riguarda il tema del dialogo religioso, ecumenico ed interreligioso, quale sfida e opportunità. È stato infine aggiunto il tema della inclusione, perché l’accoglienza cioè sia inclusiva, capace di rendere le persone partecipi a pieno titolo delle nostre comunità. Una frase intera, alla conclusione, invita a riconoscere nei migranti dei portatori di ricchezze, di conoscenza, di tradizioni.
L’ATTESA DI UNA CHIESA “NUOVA”
L’ultima proposizione vede nel testo una particolare attenzione all’attesa di una Chiesa nuova non soltanto per come dovrebbe essere per quelli che sono “fuori”, ma anche per quanti stanno “dentro”: una Chiesa cioè attenta ai suoi rapporti ad extra e ad intra.
Il paragrafo successivo parla di una Chiesa in ascolto e accogliente per spiegare meglio cosa intendere con il precedente “attenta”. Il nuovo testo sottolinea il bisogno di maggiore benevolenza tra i membri delle diverse comunità. Sono state evidenziate alcune situazioni concrete, segnalando il ruolo di movimenti, associazioni e delle realtà diverse presenti nella Chiesa. Alcuni sinodali hanno inteso un po’ ideali alcuni passaggi dello strumento di lavoro, laddove si parla della Chiesa come “laboratorio di fraternità”. Un’espressione che vuole includere però, tutto il bene che comunque si fa nelle parrocchie, indipendentemente dai limiti che in essa si vivono e da quanto si può sperimentare nel mondo. È stato poi abbreviato e sottolineato come i piccoli paesi siano per certi versi avvantaggiati nel creare occasioni di incontro tra generazioni e persone diverse, evidenziando l’importanza delle piccole realtà periferiche. È stata richiesta una maggiore unità nei cammini pastorali diocesani che potrebbe essere sanata con una maggiore sinodalità.
Una Chiesa “anima” del mondo. Il ruolo dei laici
Sono stati poi ampiamente riscritti i paragrafi dedicati ai laici, da non vedere primariamente come un aiuto al Clero. È infatti la radice battesimale che implica una vocazione missionaria dei laici, chiamati a costruire il Regno di Dio. Tra gli impegni dei laici nella costruzione del Regno è stato aggiunto l’ambito del lavoro e della cura del Creato.
Una Chiesa ministeriale
Laddove si parla di Chiesa ministeriale, si è sottolineato l’impegno dei laici all’interno della Chiesa. Si è preferito parlare di ministerialità in generale piuttosto che distinguendo tra quella maschile e femminile perché i ministeri sono indipendenti dal genere. Si è sottolineato di più il bisogno, l’attesa di comunità prive di presbiteri, evidenziando il bisogno di guide della comunità, sottolineando il bisogno di formazione per chi è chiamato a guidare una comunità (diacono, accoliti, laici) nell’intento di evitare il clericalismo, non soltanto proprio dei preti ma di chi interpreta il ministero come uno spazio di potere. Spiritualità e formazione sono proposte come rimedi.
Una Chiesa fraterna. Il servizio dei presbiteri
Infine nel paragrafo dedicato al servizio dei presbiteri si è preferito non sottolineare troppo la mancanza di preti, per evitare di leggere la ministerialità come rimedio della mancanza di clero piuttosto che come espressione di doni e carismi. Si parla, infine dell’esigenza di una maggiore condivisione e partecipazione nell’azione pastorale. È rimasta nel testo la nota relativa al fatto che l’insistenza sulla ministerialità aiuterebbe il clero a vivere meglio la propria identità.
COME PROCEDE IL LAVORO DEL SINODO
Il testo potrà essere recepito così com’è, oppure modificato secondo alcune proposte dette “modi”. Tutte le singole proposizioni saranno oggetto di votazione, ma fino a martedì 13 potranno essere presentate modifiche da parte dei sinodali comunicandole tramite mail all’indirizzo sinodo@diocesipistoia.it.
Le proposte saranno quindi condivise online per essere oggetto della discussione nella prossima assemblea generale, dove le proposte di modifiche saranno accompagnata dalla presentazione – non superiore ai tre minuti – dell’estensore.