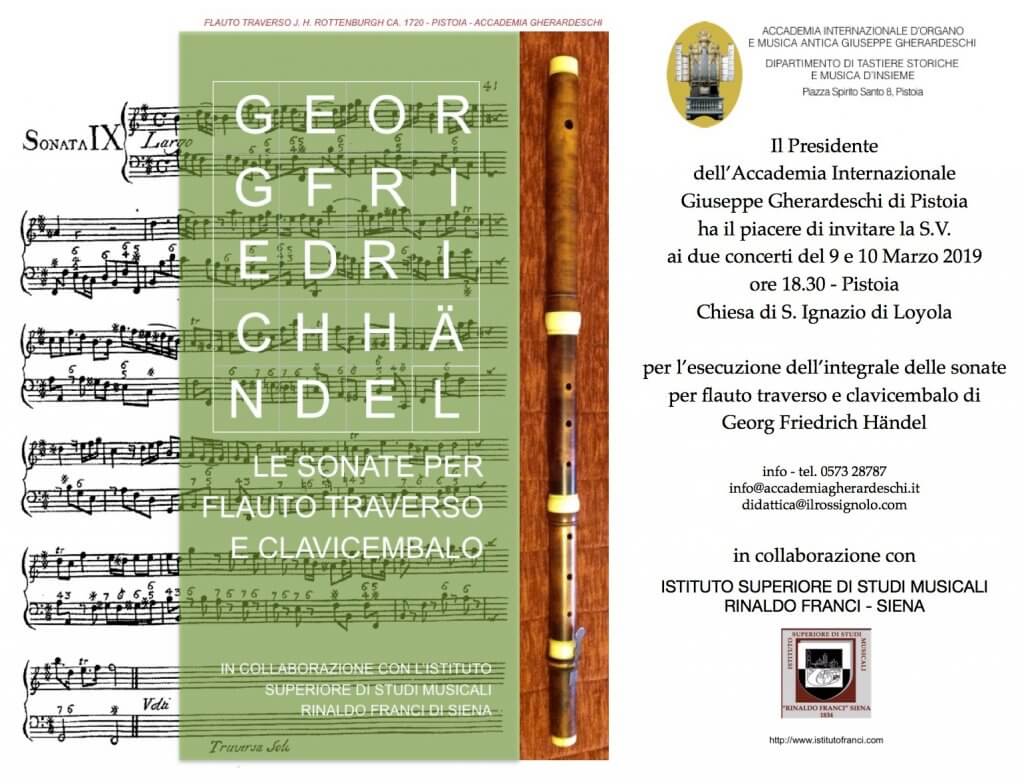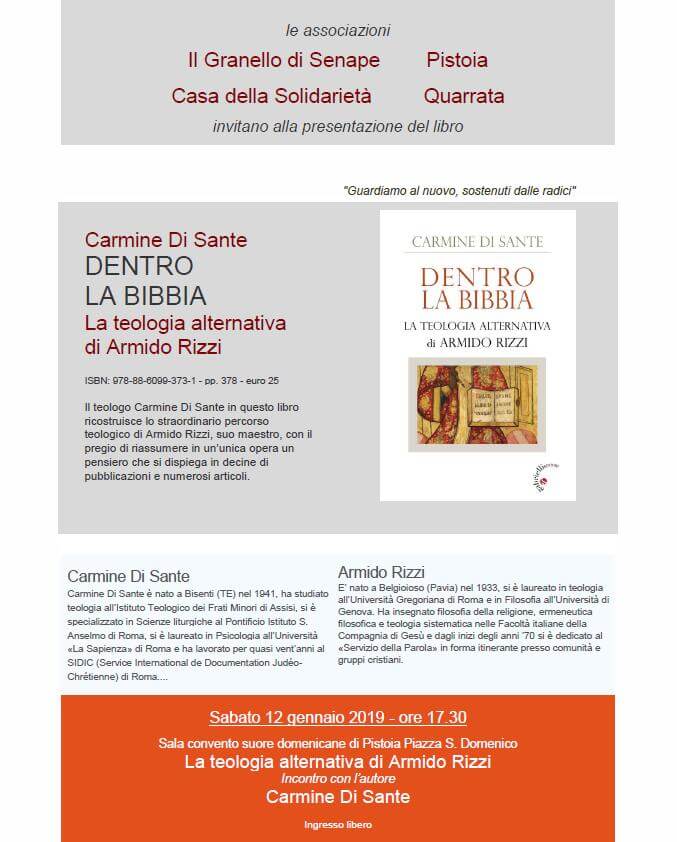“Quant’è vero Dio”: il nuovo libro di Sergio Givone
L’incontro si terrà giovedì 4 aprile alle 21 nell’aula polivalente del seminario vescovile – via Puccini, 36. Interviene Sergio Givone, filosofo, autore del volume.
Il recentissimo libro di Sergio Givone «Quant’è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione» (Edizioni Solferino, 2018) si è imposto con vigore all’attenzione pubblica, suscitando un ventaglio di reazioni singolarmente ampio, trascorrendo dagli apprezzamenti marcati (in numero rilevante) alle critiche di acuto taglio polemico (in misura ridotta). Un libro, insomma, che non lascia indifferenti.
Un’opera dai molti livelli – quelli profondi anche piuttosto difficili -, che affronta le questioni essenziali senza infingimenti e senza risposte schematizzate o ormai fuori tempo.
Al centro sta la domanda sul ruolo che la religione ha avuto, e continua ad avere, all’interno della nostra società.
Gli ingranaggi tramite cui la riflessione si articola sono rappresentati dai classici nuclei di discussione: il rapporto tra la fede religiosa e la ragione autosufficiente e quello fra legge e giustizia, il significato di “laicità”, il tema della “libertà” e quello, drammatico, della presenza del “male” e della “sofferenza” nel mondo (così inconciliabile con un Creatore onnipotente e buono), la condizione che è stato definita “l’imbarazzo del monoteismo”, la valutazione del progresso tecnologico, soprattutto di ambito genetico, la connessione tra potere temporale e potere spirituale… I nuclei tematici sono dunque quelli tradizionali, ma sono le risposte a risultare particolarmente feconde e innovative.
Per di più, le risposte di Givone rappresentano una delle difese della religione più soddisfacenti di sempre, nient’affatto protette dal paravento di asserzioni di natura dogmatica o catechistico, piuttosto intenzionalmente aperte al dibattito, in quanto formulate sul piano della ragione dialogica, ovvero quella razionalità che ama confrontarsi, migliorarsi, accrescere la propria prospettiva attraverso l’ascolto e l’assunzione degli opposti punti di visuale.
È questo lo spirito che, da sempre, anima anche il Centro culturale “Maritain”, che, partendo dalla dichiarata ispirazione cristiana, tenta di offrire a tutta la cittadinanza, a qualunque sistema di credenza faccia riferimento, un luogo privilegiato di discussione su temi rilevanti di interesse generale.
a.v.
Sergio Givone
Sergio Givone è uno dei più autorevoli filosofi della scena contemporanea non solo italiana.
Già docente di Estetica presso le Università di Perugia, Torino e Firenze, ha tenuto lezioni alle Università di Parigi, Madrid, Stanford, Tokyo e molte altre.
La sua bibliografia è piuttosto ampia, variando dal saggio di storia della filosofia, all’opera teoretica originale, fino alla forma letteraria.
Si ricordano, tra le pubblicazioni più famose:
Storia del nulla, Laterza, 1995, Favola delle cose ultime, Einaudi 1998, Il bibliotecario di Lebniz, Einaudi 2005, Storia dell’estetica, Laterza 2008, Non c’è più tempo, Einaudi 2008, Luce d’addio. Dialoghi dell’amore ferito, Olschki 2016, Sull’infinito, Il Mulino 2018.