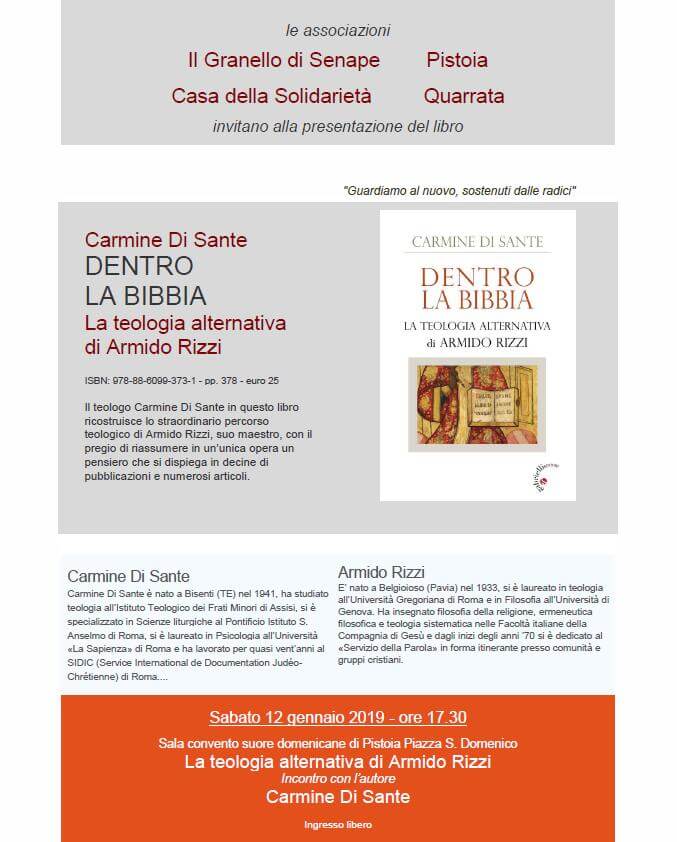L’arte appassionata di Artemisia
Lo storico dell’arte Alessandro Grassi, autore di un volume monografico sulla pittrice, tratteggia la vicenda umana e artistica dell’artista.
di don Ugo Feraci
Artemisia Gentileschi è la pittrice del Seicento più nota al mondo, forse una delle artiste più famose di tutti i tempi: la sua vicenda umana e artistica, continua ancora oggi ad appassionare. Proprio in questi giorni ha suscitato grande interesse la riscoperta di una stesura più antica sotto un suo dipinto raffigurante Santa Caterina d’Alessandria conservato alla Galleria degli Uffizi. Le analisi realizzate in occasione del restauro dagli esperti dell’Opificio delle Pietre Dure infatti, avrebbero rivelato un suo autoritratto nascosto analogo ad un dipinto acquisito recentemente dalla National Gallery di Londra. In entrambi i dipinti Artemisia presta il volto alla santa principessa martire, anche se il dipinto fiorentino sembra combinare i suoi tratti con quelli di Caterina de’ Medici, figlia del granduca Ferdinando. Insomma, Artemisia continua a far parlare di sé, lasciando tracce evidenti della sua forte personalità. Alla pittrice ha recentemente dedicato un volume monografico (“Artemisia Gentileschi”, Pacini 2018, 272 pp.) Alessandro Grassi. Alessandro è docente, storico dell’arte della nostra diocesi, ma anche iconografo: sono sue, ad esempio, le pitture per la nuova sala parrocchiale di Vignole; a lui abbiamo chiesto di introdurci alla scoperta di Artemisia e della sua arte.
Poche artiste hanno raggiunto la notorietà di Artemisia. Un successo recente che l’ha vista protagonista di numerose mostre, libri, perfino un film e un libro a fumetti. Perché?
Moltissimo è dovuto all’attualità della sua parabola esistenziale, profondamente segnata dalla violenza carnale che, diciassettenne, subì nella propria casa da parte di Agostino Tassi, un collega di suo padre Orazio (anch’egli pittore). Dopo il romanzo scritto nell’immediato dopoguerra da Anna Banti – moglie del grande storico dell’arte Roberto Longhi, il primo ad aver rivalutato l’arte della Gentileschi – il peso di questi risvolti biografici è divenuto sempre crescente, contribuendo da una parte a far conoscere la pittrice in tutto il mondo ma anche, dall’altra, a farne l’icona di pensieri e movimenti moderni, del tutto legittimi, ma storicamente estranei alla sua vicenda.
Spesso si dà una lettura femminista della sua storia, quasi che l’arte si trasformasse in occasione di riscatto di genere a partire dalla violenza. È proprio così?
È la lettura più facile e immediata – direi anzi la più “spendibile” – nel nostro tempo, tristemente segnato da innumerevoli episodi di violenza sulle donne. Tuttavia credo che il torto più grande che si possa fare, oggi, alla femminilità di Artemisia sia voler innescare a tutti i costi un nesso di causa-effetto, come se la Gentileschi sia divenuta un’artista per superare il trauma dello stupro. Credo che renda maggior onore alla donna Artemisia dire semplicemente che era una grande pittrice, e che lo sarebbe stata anche senza quella tragedia.
Artemisia aveva conoscenze importanti a Firenze, tra cui lo stesso Galileo Galilei…
Sì. In una lettera scritta molti anni dopo, nel 1635, quando già risiedeva a Napoli, Artemisia ringrazia l’anziano Galileo – ormai confinato ad Arcetri – di essersi operato, a suo tempo, per farle pagare dall’amministrazione medicea il compenso della celebre Giuditta che decapita Oloferne, oggi agli Uffizi. Ma a Firenze, dove divenne la prima donna ad essere ascritta all’Accademia del Disegno, tra il 1613 e il 1620 Artemisia aveva stretto amicizia anche con altri intellettuali, come Michelangelo Buonarroti il Giovane e Jacopo Soldani, o il pittore Cristofano Allori. Alcuni di loro furono padrini di battesimo dei suoi figli, a testimonianza di un legame umano molto stretto.
Artemisia era donna del suo tempo: un secolo, il Seicento, di passioni forti, di fede, sentimento, poesia e violenza. Che mondo descrive Artemisia nei suoi quadri?
Devo dire che non mi sembra di ritrovare un afflato autenticamente cristiano nella sua arte, sebbene abbia dipinto anche scene sacre. Senza dubbio i temi più significativi riguardano le gesta delle eroine, tratte sia dalla Bibbia che dal mondo classico – Giuditta, Susanna, Medea, Cleopatra, Lucrezia… –, che manifestano una spiccata forza morale e una volontà persino terribile. È nella raffigurazione di queste passioni che Artemisia dà il meglio di sé. D’altronde, una fra le molte discussioni erudite dell’Accademia dei Desiosi a Roma, che Artemisia frequentava, dibatteva se nell’agire umano avesse più peso l’intelletto, cioè la parte raziocinante, o la volontà, intesa come sede degli affetti: non dubito che la Gentileschi propendesse per la seconda tesi.
Qual è, per te, il suo dipinto più significativo? Perché?
Difficile rispondere; ma direi la giovanile Susanna oggi a Pommersfelden. È firmata e datata 1610 e dunque precede di un anno lo stupro da parte di Agostino Tassi. Tuttavia lo sgomento della bella ma ancor acerba Susanna, che si vede insidiata dalla concupiscenza dei vecchioni, sembra quasi una sorta di premonizione di quanto sarebbe avvenuto.